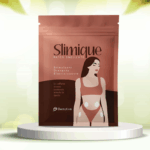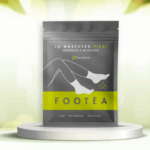La presenza di polveri sottili PM2.5 nell’aria è una delle principali cause di rischio per la salute respiratoria, in particolare nei centri urbani e nelle aree densamente popolate. Queste particelle, con diametro inferiore o uguale a 2,5 micron, sono tanto piccole da penetrare profondamente nei polmoni fino ad arrivare agli alveoli polmonari ed entrare nel flusso sanguigno. L’esposizione prolungata o a livelli elevati può portare a infiammazioni, peggioramento di malattie respiratorie croniche, asma ed aumentato rischio di malattie cardiovascolari. La questione dei limiti di sicurezza per il PM2.5 è centrale nelle politiche ambientali e sanitarie di tutto il mondo.
Limiti di sicurezza e raccomandazioni ufficiali
In Italia e in Europa, la regolamentazione delle concentrazioni di PM2.5 nell’aria si basa su norme nazionali e direttive europee, spesso elaborate alla luce delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- Il valore limite di legge stabilito dal Decreto Legislativo 155/2010 per il PM2.5 prevede che la media annuale non superi i 25 µg/m³, su base di anno civile. Questo valore è stato pensato per proteggere la maggior parte della popolazione dagli effetti avversi sulla salute determinati dall’esposizione cronica a questi inquinanti.
- Le linee guida OMS aggiornate nel 2021 sono ancora più restrittive, riconoscendo il rischio per la salute anche a concentrazioni più basse:
- Per l’esposizione a lungo termine (media annuale), la concentrazione consigliata è di 5 µg/m³.
- Per l’esposizione a breve termine (media giornaliera), il valore da non superare è di 15 µg/m³, non più di tre giorni all’anno.
Ciò significa che, mentre la legge in Italia permette fino a 25 µg/m³ in media su un anno, secondo l’OMS livelli superiori a 5 µg/m³ annui possono già aumentare il rischio di danni alla salute, in particolare per i gruppi più vulnerabili come bambini, anziani e persone con malattie pregresse.
Effetti sulla salute delle polveri PM2.5
Il motivo di tanta attenzione ai livelli di PM2.5 deriva dalla capacità di queste particelle di penetrare profondamente nei polmoni e dall’accumularsi delle evidenze scientifiche sulla loro pericolosità. Esse provengono sia da fonti naturali che antropiche: traffico automobilistico, combustione domestica di legna o carbone, attività industriali e processi chimici urbani.
I principali effetti sanitari attribuiti al superamento dei limiti di sicurezza di PM2.5 includono:
- Irritazione e infiammazione delle vie respiratorie anche in soggetti sani.
- Esacerbazione di patologie croniche come asma e BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva).
- Aumento del rischio di infezioni polmonari e del numero di ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie.
- Effetti sistemici: una volta raggiunto il flusso sanguigno, il PM2.5 può favorire fenomeni infiammatori cronici, aumentare la coagulabilità del sangue e favorire lo sviluppo di malattie cardiovascolari.
- Incremento stimato del rischio di tumore polmonare nelle popolazioni esposte a concentrazioni elevate per lunghi periodi.
Secondo l’OMS, nessuna soglia può essere considerata completamente sicura per la salute umana, ma tanto più bassi sono i livelli medi di esposizione, tanto minori sono gli effetti avversi sulla popolazione generale.
Popolazioni particolarmente a rischio e strategie preventive
Alcuni gruppi di persone sono maggiormente esposti ai rischi dell’inquinamento da PM2.5. Tra questi troviamo:
- Bambini e neonati, i cui polmoni e sistema immunitario sono ancora in via di sviluppo.
- Anziani, con minore capacità di difesa dai danni cellulari provocati dagli inquinanti.
- Persone con patologie cardiache, asma, BPCO o altre malattie respiratorie croniche.
- Individui che trascorrono molto tempo all’aperto, come operatori ecologici, lavoratori edili, sportivi.
Azioni individuali e collettive possono contribuire alla riduzione dell’esposizione:
- Monitorare la qualità dell’aria attraverso app e siti istituzionali, adottando precauzioni nei giorni di allerta.
- Limitare lo svolgimento di attività fisica intensa all’aperto durante i picchi di inquinamento.
- Ridurre l’uso di mezzi privati a favore dei trasporti pubblici, biciclette o camminate.
- Preferire il riscaldamento domestico più pulito (gas naturale rispetto alla legna o carbone).
- Installare sistemi di filtrazione indoor nelle zone a maggiore rischio.
Quadro normativo italiano ed europeo
Il tema dei limiti agli inquinanti atmosferici è in costante evoluzione, in risposta alle nuove conoscenze scientifiche. La Direttiva 2008/50/CE dell’Unione Europea rappresenta il quadro di riferimento per tutti gli Stati membri; il recepimento in Italia è avvenuto attraverso il già menzionato Decreto Legislativo 155/2010. Attualmente, il valore limite annuale per il PM2.5 fissato in Italia e in tutta l’Unione è di 25 µg/m³, ma molte regioni italiane superano ancora frequentemente i livelli consigliati dall’OMS.
Le ultime revisioni delle linee guida OMS suggeriscono di adottare in futuro valori ancor più restrittivi sulla falsariga di quanto già avviene in alcune città e Paesi particolarmente attenti alla tutela della qualità dell’aria. In alcune aree, le amministrazioni comunali scelgono già di adottare limiti più severi su base volontaria e implementano interventi di circolazione limitata, creazione di zone a traffico limitato, incentivazione della mobilità elettrica e della forestazione urbana.
Sviluppo e monitoraggio futuro
Il futuro dell’approccio normativo e scientifico al problema del PM2.5 vede una convergenza verso valori guida sempre più bassi, associati a politiche più incisive di riduzione delle emissioni. L’attenzione crescente si focalizza adesso anche su aree rurali e non soltanto urbane, nella consapevolezza che le povere sottili non conoscono confini amministrativi e possono viaggiare per centinaia di chilometri. Strumenti di monitoraggio sempre più precisi, basati sulle tecnologie di misurazione avanzate, stanno dando un impulso decisivo alla comprensione e alla gestione di questo problema di sanità pubblica globale.
In definitiva, mantenere i valori di PM2.5 il più vicino possibile ai livelli raccomandati dall’OMS, e quindi ben al di sotto dei limiti di legge attualmente in vigore, rappresenta la strategia migliore per proteggere la salute dei polmoni e prevenire patologie gravi legate all’inquinamento atmosferico, puntando sulla prevenzione e sulla consapevolezza individuale e collettiva.